Articolo precedente:
Il secolo XIX non è stato, in letteratura, solamente Romanticismo e Liberalismo… – I
Il letterato
Alla lettura dei “buoni scrittori” italiani il Vallauri fu indirizzato (cfr. Vita I, cap. 2) dal padre, che gli fece leggere il Galateo del Della Casa, Del governo della famiglia di Agnolo Pandolfini, e, tra i moderni, Metastasio e Goldoni, dalla cui lettura egli trasse “incredibile piacere”.
Dopo queste prime letture, per così dire, domestiche nacque in lui, al tempo degli studi a Mondovì, il gusto per i trecentisti, poiché alla scuola del suo professore di Umanità, don Giovenale Vastapani, «sentii per la prima volta nascere in me vivissimo il desiderio di imitare l’aurea semplicità dei trecentisti» (Vita I, cap. 4). Questo interesse crebbe poi negli anni dell’università, alla scuola del Biamonti, il quale non solo consigliava la lettura degli autori del Trecento, ma li utilizzava lui stesso come modelli di stile e di eloquenza[1]. Tra gli scrittori del Trecento non poteva mancare, ovviamente, Boccaccio, dal Vallauri avidamente letto durante il soggiorno a Chiusa (aprile-novembre 1821) nel periodo di chiusura dell’università a causa dei moti rivoluzionari[2].

Le letture dei trecentisti e, aggiungiamo, anche dei cinquecentisti portano come frutto la decisione di scrivere due novelle, che ritraggono personaggi ed eventi delle due città in cui il Vallauri le concepisce: nel 1835, a Vercelli, la novella di Francesco Pecchio da Vercelli, e l’anno successivo, ad Alessandria, quella di Camilla Faa di Bruno. Bisogna attendere poi circa dieci anni per trovare una nuova opera in prosa narrativa italiana, cioè Il cavalier Marino in Piemonte. Episodio della Storia Subalpina del secolo XVII, pubblicata dalla Stamperia Reale di Torino nel 1847: proprio partendo da quest’opera, da lui definita un “romanzo storico”, il Vallauri nella Vita (III, cap. 2) apre una polemica coi romanzi della sua età presente, evidentemente quelli di impostazione romantica e sentimentale, dicendo che
I padri ed i maestri possono metterla [la sua opera sul cavalier Marino; n.d.a.] nelle mani dei giovani, senza correre il rischio di corromperne il cuore con quelle descrizioni di violente e sconsigliate passioni, le quali pur troppo s’incontrano nei romanzi, e dipingono una vita fittizia e artificiale.
Solo col 1860 però il Vallauri comincia, firmandosi col nome arcadico di Filarco Epidaurico, a scrivere e a stampare con sistematicità novelle[3], la cui motivazione può essere letta nella Vita (III, cap.6), dove l’autore dice
Già da parecchi anni, mentre io me ne stava nella mia villetta di Mondovì durante il mese di settembre, per fuggire la mattana e per esercizio di stile aveva in usanza di scrivere una novelletta; in cui mi proponeva principalmente di sferzare alcune maccatelle della nostra età.
[…]
E così […] io mi studio di notare altri vizi de’ nostri giorni, sollevando a più nobile uffizio la novella, usata dagli antichi a solo diletto e passatempo di scioperati lettori.
Pertanto gli autori “antichi” (allusione a Boccaccio, che pure – e lo vedremo – è modello di lingua per il Vallauri) hanno usato la novella solamente come strumento di divertimento e di svago per i lettori, mentre intenzione del Vallauri è quella di usare questo genere letterario come gli autori latini avevano usato la satira, per sferzare cioè i cattivi costumi, oltre che come “esercizio di stile”. E così il suo ossequiente scolaro Osvaldo Berrini, nella prefazione alla 5a edizione delle Novelle, può affermare
Giova anzitutto avvertire l’intenzione dell’autore, che fu di torre semplicemente a prestito la forma della novella in servizio della satira, per modo che il rispetto epico viene ad essere subordinato affatto al satirico. Per la qual cosa non devesi in queste novelle cercare gran copia, varietà ed intreccio d’azione; ma piuttosto una censura di costumi, fatta con quella giovialità, che è propria di Luciano. Che se al lucianesco sembrerà mescolarsi talvolta qualche sprazzo di aristofanesco e di menippeo, non parrà strano, chi guardi la condizione dei tempi più degni della bile di Persio e Giovenale, che della lepidezza di Orazio.
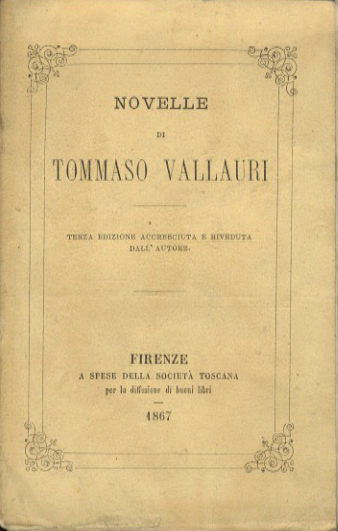
Parole simili si potevano già leggere nella Prefazione alla 3a edizione (Firenze 1867), scritta dal fratello dell’autore, il canonico Pier Antonio
Queste Novelle […] mio fratello Tommaso scrisse per mordere alcuni vizi della nostra età
[…]
egli crede, e non senza ragione, che la Novella, usata dagli antichi a solo diletto e passatempo di scioperati lettori, possa, a’ giorni nostri, sollevarsi a più nobile uffizio, e tener le veci della Satira.
Il carattere prettamente satirico delle novelle è ulteriormente confermato ancora dal Vallauri in un passo della sua Vita, in cui si specifica inoltre che
Le mie Novelle sono d’indole satirica, com’è detto nella prefazione. Ma descrivendo io certe stravaganze della nostra età, non ho inteso di ferire alcuno in particolare. E nessuno perciò dee prendersi a male gli scherzi, con cui vo pungendo alcuni cervelli balzani dei nostri giorni, perché il novellatore e il poeta drammatico non hanno l’obbligo di domandare il permesso a nessuno, quando vien loro la frega di dipingere uomini strani che, novelli Calandrini, rallegrano le brigate coi loro nuovi costumi. Che se alcuno in queste mie fantastiche pitture riconosce per avventura se stesso, egli fa troppo onore all’autore, il quale mostra di saper imitare bene la natura, anzi di essere un valoroso fotografo. Del resto, novellando e scherzando, io mi proposi eziandio di offerire agli studiosi alcuni modelli di forbita lingua italiana[4].
Ecco dunque gli intendimenti dello scrittore: satireggiare i propri tempi, senza però voler attaccare qualcuno in particolare (intenzione comunque non del tutto rispettata…), ed offrire esempi di buona lingua italiana (ricordiamo che egli era stato accolto tra gli accademici della Crusca dal maggio del 1869). Inoltre, come apprendiamo da una lettera del novembre 1869[5] al barone Domenico Carutti di Cantogno, un ulteriore scopo dello scrivere novelle era per lui quello di informare il pubblico dei, noi diremmo, “non addetti ai lavori” della situazione, per il Vallauri, terribile, in cui versavano allora gli studi classici in Italia, che correvano il rischio di essere “contaminati” dall’invasione dei filologi tedeschi.
L’intendimento satirico apparirà evidente anche dalla sola lettura dei riassunti delle Novelle che presentiamo qui di seguito, mentre per chiarire il secondo (quello relativo alla lingua) darò alcuni esempi di termini e locuzioni evidentemente ripresi da scrittori toscani dei buoni secoli della lingua letteraria: Trecento e Cinquecento.
Vediamo ora gli argomenti, in sintesi, delle 15 novelle del Vallauri, ciascuna con la data di edizione.
I. Il barbiere del Rinchiuso (1860)
Simone, un barbiere dei dintorni di Mondovì, persona seria e stimata da tutti, illuso dalla predizione di una zingara, manda i suoi due figli a scuola e su di essi costruisce illusioni e speranze. Morti però prima uno dei due figli (Bartolomeo) e, due anni dopo, anche il padre, l’altro figlio (Giulio), presi gli ordini sacri, si mette a fare il precettore. Scoppia la rivoluzione francese e Giulio torna allo stato laicale, entrando prima nell’amministrazione pubblica e poi, uscitone, tiene scuola privata di lingua francese, scrivendo un’opera sulla “inutilità dello studio del latino”, che viene però stroncata. Il giovane deve quindi adattarsi al ruolo di maestro di scuola.
II. Il mago della Garzegna (1861)
Protagonista è la figura del padre scolopio G. B. Beccarla, famoso studioso di fisica, originario di Mondovì. È lui il “mago”, tenuto in sospetto dai suoi vicini per i suoi strani esperimenti, a tal punto che un giorno i contadini assediano la sua casa rovinandovi mobili ed arredi, ma non trovandovi fortunatamente il “fattucchiero”. La novella si conclude con la partenza del Beccarla per Torino, dove pubblicherà i risultati dei suoi studi alla Garzegna, e con una breve biografia del Beccarla stesso; non mancano alcune osservazioni sull’ingratitudine dei contemporanei, così profonda che il nome del Beccarla, nonostante i suoi studi, neppure compare tra i Soci dell’Accademia delle Scienze di Torino.
III. I sinonimi di un Metodista (1862)
Ambientata in Veneto, la novella ha come protagonista un maestro di scuola, ser Felice, che coltiva con interesse, a differenza di moltissimi maestri contemporanei del Vallauri, gli studi sia di lingua latina che di volgare; egli è amato e stimato dai suoi compaesani, ma non altrettanto fuori del suo paese. Un ispettore, che rappresenta la boria e la vanagloria dei sostenitori del nuovo metodo di insegnamento (i metodisti), visita la scuola di ser Felice ed ha con lui una discussione sui diversi metodi di insegnamento; segue poi un’altra discussione sul significato di due sinonimi (morbido-liscio) nella quale ser Felice, pur essendo dalla parte della ragione, è obbligato a tacere dall’arroganza dell’ispettore. Alla fine, però, il maestro gioca, con l’aiuto di alcuni amici, un terribile scherzo all’ispettore.
IV. L’epigrafista di Monreale (1863)
La figura del protagonista (Ser Giacometto della Tonnara), che il Vallauri afferma essere realmente vissuto verso la metà del secolo XVIII e che ricorda per certi versi il personaggio di don Cono Canalà in I Viceré di Federico De Roberto (parte I, cap. 1), è quella di un letterato siciliano presuntuoso e maniaco delle epigrafi, che decide di fondare insieme ad alcuni amici un’accademia epigrafica. La novella si chiude con una brutta avventura del protagonista ad opera di una brigata di giovani.
V. La Bengodi dei Calandrini (1864)
Il racconto si apre con la descrizione di un’isola, una sorta di Utopia, in cui vivono i discendenti di coloro che, fuggiti da Aquileia al tempo delle scorrerie degli Unni di Attila, qui si erano rifugiati. Costoro, che tra di loro parlano ancora latino, rappresentano, con le loro istituzioni politiche, civili e scolastiche, gli ideali di perfezione sognati dal Vallauri. All’isola giunge però una nave di Metodisti (i Calandrini), la cui pochezza intellettuale e culturale viene messa in risalto dal confronto con le istituzioni dell’isola. Costoro comunque, dopo un fiorito discorso del loro capo (il Gran Cucù), riescono ad impadronirsi prima del governo dell’istruzionee poi di quello di tutta l’isola.
VI. La maestra di scuola (1866)
Due sono i filoni polemici percorsi in questa novella: i pericoli e i danni provocati da coloro che vogliono “sollevarsi al di sopra della propria condizione” e la rovina provocata dai nuovi metodi di insegnamento. Emblematica è la figura della protagonista (Camilla), una ragazza torinese di umile condizione che, fuorviata dai discorsi di un’amica, invece di accontentarsi del suo stato, frequenta la scuola di metodo (cioè l’istituto magistrale); dopo un’infarinatura di istruzione, essa ottiene il diploma e, subito dopo, un posto di maestra in un paese del vercellese, dove vive una vita traviata e disinibita, fino al matrimonio con un ispettore delle scuole, che altri non è se non un frate che, gettata la tonaca, ha fatto carriera nell’amministrazione statale. Abbandonata poi dal marito per un’altra donna, Camilla si ammala e muore, nonostante le cure amorevoli del padre che, perdonatala, l’ha riportata a casa.
VII. Il pedagogo subalpino (1867)
La novella si apre col ritratto ideale del pedagogo per il Vallauri, che precisa anche le sue opinioni sui maestri dei suoi tempi. La storia è quella di un mercante piemontese arricchito che, basandosi sulla lettura di giornali “moderni”, cerca per i suoi due figli un maestro che lasci loro piena libertà in fatto di religione. Il maestro viene trovato e se ne racconta la storia: è anche lui un prodotto delle scuole di metodo, già cacciato dalle scuole pubbliche di Torino per alcuni suoi illeciti; costui inizia il suo lavoro inculcando nei ragazzi idee anti-religiose e non facendo loro studiare la grammatica italiana e latina, poiché in effetti non le conosce neppure lui. Dopo alcune vicende in casa del commerciante, il maestro si congeda e torna al suo villaggio, dove in parte si ravvede.
VIII. Il castello della Chiusa (1868)
È la narrazione storica della vita e degli studi di Anastasio Germonio[6], arcivescovo di Tarantasia, vissuto nel secolo XVI. Anastasio, mentre ragazzo si trova nel castello di Chiusa (il cui territorio viene descritto dal Vallauri nelle prima pagine della novella), conosce il Conte Falchetto, che con l’esempio della sua dottrina lo spinge a non intraprendere la carriera delle armi, ma quella delle lettere, in cui viene istruito dapprima dal maestro cuneese Francesco Cagnoli e poi, a Torino, dai gesuiti. Studia poi il diritto (civile e canonico), prende i voti, e nel 1579 si laurea a Torino. Nel 1580 è professore ordinario di Diritto canonico, va poi a Roma, diventa arcivescovo di Tarantasia, e nel 1612 viene inviato dal duca Carlo Emanuele I a Madrid, dove muore nel 1627.
IX. L’Apocoricosi (1869)
Il titolo è chiaramente esemplato sull’Apocolocyntosis di Seneca, di cui il Vallauri imita anche l’argomento: la morte di un personaggio famoso (Friedrich Ritschl, rivale del Vallauri), il suo arrivo nell’aldilà e la condanna, pronunciata dal tribunale di Eaco su proposta dei più grandi scrittori latini (principale accusatore è Plauto), ad essere trasformato in un pallone. È la novella più scopertamente, personalmente (in contrasto con quanto scriverà nella Vita; cfr. supra) e biliosamente polemica tra quante scrisse il Vallauri, che se la prende con “l’universo mondo”: dal Ritschl al Wolf al Mommsen, dai sostenitori italiani del metodo tedesco al Cavour, non citato espressamente ma chiaramente riconoscibile.
X. Lo Spiritismo (1870)
La novella narra la storia di un certo Lorenzo Altieri, che si spaccia per gran signore tra i compagni di scuola, riuscendo così a entrare in amicizia con un giovane ricco. Lorenzo si iscrive all’università, ma decide ben presto di dedicarsi alla carriera musicale, per ambizione di fama e di ricchezze. Interessato allo spiritismo ed al magnetismo animale, il protagonista conosce un medium dal quale, evocato lo spirito del re Mida, si fa predire il futuro, ovviamente ricco di successi. Decide quindi di seguire Elvira, una cantante d’opera, con la quale intraprende anch’egli la carriera di cantante, ottenendo grandi successi in Spagna. Si reca quindi a Buenos Ayres, dove sposa una ricca ereditiera, ma dove va incontro anche alla sua rovina, economica e famigliare. La morale conclusiva della novella è quella di non dar mai retta ai fenomeni legati allo spiritismo.
XI. Il sogno di un Pedante (1871)
Il milanese Andreuccio è un pedante, mediocre e superbo, che crede di essere il “principe dei latinisti viventi” e gran compilatore di altrettanto mediocri libri scolastici, soprattutto antologie, libri di storia e grammatiche latine. Decide quindi di fare il giornalista e fonda un suo giornale («La vipera»), che, come già i suoi libri, non ha un grande successo. La novella si chiude con Andreuccio che racconta un suo sogno in cui ha visto il destino infernale che lo attende dopo la morte.
XII. Le nozze della Filologia e di Mercurio (1872)
La scena è a Berlino, dove avvengono le nozze tra la filologia e Mercurio[7]. Si descrive dunque una processione di società letterarie e mercantili, tra cui spiccano quelle dei filologi, dei tipografi e librai, dei giornalisti e degli autori di antologie. Viene poi descritto il palazzo della filologia e vengono riportati il discorso degli autori di libri scolastici e quello di un veneziano. Segue il confronto tra i due metodi di studio dell’antichità classica: quello “retorico” (seguito dal Vallauri) e quello “filologico”; vengono infine presentate una gran fiera di libri, una giostra di cavalieri ed un concerto.
XIII. L’etimologista (1873)
A Firenze, negli anni dell’autore, vive un patito di etimologie, di cui si riporta la descrizione. Il protagonista, tanto vanesio quanto sciocco, si offre come professore di etimologia al Regio Istituto Superiore della sua città e, per celebrare la nomina, invita a pranzo gli amici (viene descritta la sala da pranzo, con una disquisizione sulla pittura). Nel bel mezzo del banchetto arriva però la delusione: il ministro non ha accettato la sua candidatura perché egli né ha studiato le etimologie secondo il metodo tedesco né conosce discipline quali la glottologia e la filologia.
XIV. L’antiquario della Valle di Maira (1874)
Protagonista è il medico Maurizio Rolli, vissuto verso la metà del Settecento. Dopo avere studiato a Torino, dove cominciò ad interessarsi anche alle antichità (soprattutto monete ed iscrizioni), torna al suo paese in val Maira (in provincia di Cuneo) per esercitare la sua professione di medico. Col tempo nasce in lui il desiderio di creare, con l’aiuto di un amico, false monete antiche e false iscrizioni, così da crearsi fama di archeologo ed antiquario presso i dotti. Tutto procede per il meglio finché, per l’invidia del sindaco del paese, viene denunciato come falsario al governatore di Cuneo, che lo fa arrestare. Chiarito l’equivoco, il Rolli può tornare libero e riprendere la sua vita, rinunciando comunque alla falsificazione di epigrafi e monete antiche.
XV. Una vendetta delle Donne Torinesi (1875)
Ambientata nel secolo XVI, racconta la storia di Giovanni Nevizzano, prima studente e poi professore di diritto presso l’Università di Torino. Giovane di poca propensione alle feste ed ai divertimenti, si innamora di una ragazza (Albertina), la cui madre, vedova, seguendo le indicazioni di un ecclesiastico, la dà invece in moglie ad un vecchio nobile. Offeso da questo comportamento, il Nevizzano scrive un’opera, la Selva nuziale, in cui, per vendicarsi del torto subito, attacca le donne con ferocissimi argomenti. In conseguenza di ciò le donne torinesi, elette cinque di loro per esaminare il caso, si riuniscono e decidono che Giovanni sia bandito dalla città fino a che non faccia pubblica ammenda della sua colpa, cosa che egli fa in capo a pochi giorni.
Come già la Vita, anche le Novelle troviamo infarcite di polemiche, senza risparmiare, come già abbiamo osservato, i nomi di parecchi dei suoi avversari (contrariamente a quanto il Vallauri stesso dichiara nella Vita III, cap. 12). I principali argomenti di cui il Vallauri, spesso inveendo, si occupa sono sostanzialmente i seguenti: i libri moderni, e in particolare le antologie e i romanzi (VI, 223, 234, 254; VII, 195sgg.; X, 298; XI, 324, 332, 347), il governo (I, 44), il tempo presente (I, 14; II, 49, 74; VII, 180sgg.; VIII, 226sgg., 235; IX, 264sgg.), le malevolenze e gli intrighi (III, 84), i divertimenti (III, 91), i “Metodisti” (V, 184; VI, 206; VII, 185sg.), gli scrittori del Seicento (V, 197), le donne intellettuali (VI, 227sgg.), i frati sfratati (VI, 237sgg.), gli esami (X, 292), la filologia “moderna” (X, 314; XI, 368; XII, 394), la stampa, i giornali e i giornalisti (XII, 397, 402). Tra i personaggi satireggiati troviamo Cavour (IX, 248), Friedrich Ritschl e Theodor Mommsen (tutta la novella IX, e in particolare pp. 251 e 254; XIV, 9). Non mancano tuttavia gli elogi espliciti, soprattutto auto-elogi (IX, 254sgg.), ma anche di amici, come Pietro Fanfani (XI, 347) o del metodo umanistico-retorico (XII, 366).
A conclusione di questa parte relativa alle Novelle vorrei ancora citare due passi, da cui emergono, sinteticamente ma con estrema chiarezza ed efficacia, quali fossero gli ideali vallauriani: una è la descrizione di alcune caratteristiche dell’isola utopica di Bengodi (novella V, La Bengodi dei Calandrini, pp. 169-175, passim)
Né il valente Loredano […] aveva dimenticato quelle parti, che nel reggimento di una città sono più importanti: vo’ dire la cura della religione, della morale, e il buon ordinamento degli studi e della coltura della gioventù. […] saviamente estimando, che a rendere profittevole l’insegnamento, non meno che l’ingegno e la dottrina, occorresse la santità dello insegnante. Comandò che ad ogni classe di cittadini fosse aperto egualmente l’adito alle scuola, perciocché non di rado i cieli concedono al povero quella scintilla che negano a colui, il quale nasce fra gli agi di ricca e chiara famiglia. Nelle scuole vietò sopra ogni altra cosa il soverchio delle materie da studiarsi: di che vuolsi a lui dare gran lode. Imperciocché la moltiplicità delle cose insegnate non si scompagna mai della leggerezza degli studi; e questa genera l’ignorante arroganza, madre feconda di gravi sciagure agli uomini. Raccomandò molto caldamente la severità degli esami, senza di cui la scuola diventa un ritrovo di scioperati, che volgono a strazio del maestro la sua inopportuna indulgenza. Negli studi superiori non fu omesso l’insegnamento di nessuna di quelle scienze che rispondevano ai bisogni di quella età; e, qual conveniente preparamento ad esse, fu ordinato lo studio degli scrittori greci e latini, tanto sacri quanto profani;
e l’altra è la descrizione del pedagogo ideale nella novella VII (Il pedagogo subalpino, pp. 177sg.)
Ei fu già tempo, che volendo un dipintore ritrarre sulla tela un pedagogo, non avrebbe potuto altrimenti figurarlo che sotto le sembianze di un uomo di mezza età, dalle guance pienotte e rubiconde, dalla zazzera ben pettinata e incipriata, colla camicia sporgente un dito traverso dalla manica dell’abito nero, e con fibbie d’argento splendienti sulle scarpe. E sotto un tal sembiante nascondevasi per lo più un buon sacerdote di santa vita; il quale ancorché non fosse di svegliato ingegno, pur non mancava di una cotale dirittura di giudizio, ed era bene spesso assai valente in grammatica. Con questo mezzano corredo di sapere l’antico pedagogo acconciatasi al servizio di qualche nobile ed agiato signore, per ammaestrarne i figliuoli, menarli fuori al passeggio, e dire la messa a tutta la famiglia, quando la state e l’autunno essa andava a starsene in contado. Riverito, come si conveniva alla sua dignità sacerdotale, era sovente il consigliere di casa, il paciere, che recava a concordia i disuniti animi dei famigli, e da tutti era per antonomasia chiamato l’Abate.
Cotale fu insino al tempo dei nostri padri il pedagogo in Piemonte. E da esso apprendevano i fanciulli delle più ragguardevoli famiglie non solo il leggere, lo scrivere, e i primi elementi delle lettere italiane e latine; ma eziandio quelle buone massime religiose e morali, che eran loro di guida negli anni più maturi, e li trasformavano in onesti e riputati cittadini.
Lo stile delle novelle è generalmente classicheggiante, elevato non solo dall’uso di toscanismi, ma anche di forme puristiche ricavate dalla lettura e dallo studio dei “buoni” autori dei secoli “aurei” della lingua letteraria italiana[8], mescolando l’autore termini e locuzioni di autori e di secoli differenti[9]. Non mancano tuttavia dei solecismi, anche se è comunque da verificare se tali errori non siano da imputare a refusi di stampa.
Tra le forme più apertamente toscaneggianti[10], e desumibili quindi dalla lettura di autori precedenti, possiamo annoverare: ben assettato (I, 12, e assettatuzzo, VI, 205, presenti entrambe le forme in Boccaccio), diciferarmi (I, 22, e diciferati, VIII, 219; Grazzini, Firenzuola), gnaffe (I, 26 e VI, 204; Boccaccio, Bembo), caldano (I, 30; Buonarroti il giovane), la cattivella della Sandra (I, 32, e cattivello, III, 113 e ancora il cattivello del pedante, XI, 323; Boccaccio), ferrigno e robizzo (II, 50; Machiavelli, Mandragola), nabissare (II, 57, e si nabissava, XIII, 391; Boccaccio, Sacchetti, Varchi), avacciare (II, 62; oltre a Dante, anche in Boccaccio, Compagni, Villani), indozzamenti (II, 66; Boccaccio, Buonarroti il giovane), E di tanto l’amò Iddio (II, 69; Boccaccio), in casa il maestro (III, 103, e in casa il conte Quattrini, III, 106, in casa messere Giacometto, IV, 156, in casa la sorella, VI, 204; Boccaccio), schiccherasse (IV, 122; Boccaccio, Caro), dolciato (IV, 128; Boccaccio), accoccare (IV, 130; Dante, Pulci, Bandello), trecca (IV, 134; Villani, Sercambi, Alberti), giungere il merletto alla schiaccia (IV, 152), sezzaia (IV, 155; Boccaccio), si rimpannucciarono (V, 194), acciabattar (V, 196, e acciabattare, XI, 323, e acciabattò, VII, 190; Buti), strebbiarsi (VI, 203), atteggevole (VI, 205; Vocab. Crusca), sbiasciavano (VI, 210), coticoni (VI, 226; Aretino), goccioloni (VI, 226; Boccaccio), codiare (VI, 246; Buonarroti il giovane), pecoreccio (VII, 182; Boccaccio, Varchi), uscire de’ cenci (VII, 188; Caro), bene addanaiata (VII, 188, e addanaiato, X, 288; Alberti, Sacchetti), cotal grado ha chi tigna pettina (VII, 189), valsente (VII, 191), spruzzolava (VIII, 212; Firenzuola, Sacchetti), mi abbarrava la via (VIII, 212; Villani), Di’ tu se io vi fu’ mai. Sì vi fui così una volta come cento… (VIII, 216; Boccaccio), lingua tabana (VIII, 224; nel senso di “persona malfidente”; Varchi), bezzi (IX, 245; Aretino), si sta in barba di micio (IX, 247), rovigliare (IX, 251; Doni, Gelli, Varchi), siete montato in bigoncia (IX, 252), maniata (IX, 263, e maniato, X, 288; Grazzini), meriggiando (IX, 263; Caro), stare ai panni (X, 290; Dante), sfondolato (X, 291; Boccaccio, Grazzini), panieruzzolo (X, 308; Caro), berlingaccio (X, 307; Sacchetti, Vocab. Crusca), spulezzarono (X, 308; Lippi, Pulci, Ariosto), attutato (X, 309; Boccaccio), galloria (XI, 318; Aretino, Boccaccio, Buonarroti il giovane), smugendo (XI, 322), aiuolo (XI, 323; Boccaccio, Sacchetti), cibreo (XI, 323; Grazzini), requiare (XI, 324; Boccaccio), a spilluzzico (XI, 325; Villani, Varchi), ghiottornia (XI, 326; Villani, Boccaccio), lunediana (XI, 329; Lippi), pur me (nel senso di “verso di me”, XI, 330; Dante), ormando (XI, 339; Caro), bruzzaglia (XII, 357; Buonarroti il giovane), complire (XII, 359; Buonarroti il giovane, Caro), civanzo di mona Ciondolina (XII, 363; Buonarroti il giovane, Sacchetti), cianciafruscole (XII, 381), lanternuto (XIII, 385; Buonarroti il giovane), si ringalluzzava (XIII, 386; Firenzuola), arietando (XIII, 387; Buonarroti il giovane), infermiccio (XIII, 392; Alberti, Machiavelli, Aretino), acculattando (XIII, 402; Buonarroti il giovane), cioncando e ricioncando (XIII, 412; Sacchetti), poltracchiello (XIV, 8; Sacchetti), scapucci (XIV, 32).
[1] Cfr. Vita I, cap. 6: «[…] ci sentivamo rapiti alle parole del Biamonti, che ritraevano del fare semplice e schietto dei trecentisti». Il giudizio sui trecentisti è confermato anche in un passo della novella I sinonimi di un metodista, là dove il Vallauri, accennando al modo di scrivere del protagonista, dice: «E il suo scrivere italiano era non pur corretto, ma notabile eziandio per quella elegante semplicità, che si ritrae dalla lettura dei nostri scrittori del trecento».
[2] Cfr. Vita I, cap. 7: «[…] io mi diedi a leggere con molta attenzione alcuni classici latini ed italiani, e specialmente Cesare, Sallustio, Dante e il Decamerone del Boccaccio. Coll’assidua e ripetuta lettura di questi scrittori e collo studiarne a memoria i brani migliori…».
[3] Il testo delle Novelle verrà citato secondo le due edizioni che ho potuto consultare, cioè la 3a, del 1867, per le prime sei novelle, e la 5a, del 1873, per quelle dalla settima alla tredicesima (Novelle di T. V. Terza edizione accresciuta e riveduta dall’Autore; Firenze 1867 e Quinta edizione riveduta ed accresciuta dall’Autore; Torino 1873). I passi delle novelle verranno citati col loro numero d’ordine progressivo (romano) e il numero della pagina (arabo). Le due novelle non comprese nella 5a edizione, cioè L’antiquario della Valle di Maira e Una vendetta delle Donne Torinesi, saranno invece citate col loro numero d’ordine (rispettivamente XIV e XV), seguito dal numero arabo della pagina della loro edizione torinese del 1875. Ricordo ancora che delle novelle vallauriane si sono avute in complesso ben sette edizioni: la 2a (in realtà la prima in volume) è del 1864, la 3a del 1867, la 4a del 1868, la 5a (con prefazione del Berrini) del 1873, la 6a (curata dal padre scolopio Mauro Ricci) del 1881 e la 7a del 1892. Di queste sette edizioni le prime due furono stampate a Firenze, la 4a e la 5 a Torino, la 6a a Siena. L’anno di edizione delle singole novelle sarà riportato più avanti, nel testo, quando se ne riassumeranno gli argomenti. Infine, oltre alle novelle vere e proprie, tra le opere narrative occorre ricordare ancora il cosiddetto Episodio drammatico che, scritto nel 1870 in occasione della polemica sul vocabolario con don Giovanni Perosino, trovò poi collocazione nel cap. 6 del libro III della Vita.
[4] Cfr. Vita III, cap. 12.
[5] Nella parte finale di questa lettera (conservata nel Fondo Prior della Biblioteca Civica di Torino, coll. 54/2), dopo aver passato in rassegna altri argomenti, il Vallauri cita la sua polemica col Mommsen e col Ritschl a proposito di Plauto e così conclude: «E questi pareri Ella vedrà ristampati nelle note alla mia Apocoricosi, che sto pubblicando di questi giorni, e che mi fornì il modo di dare il resto del Carlino al Mommsen ed al Ritschl. V. S. non mi rimproveri la mia insistenza su questo proposito. L’anno scorso io scrissi pei dotti. Ora mi preme, che anche gli uomini nuovi, che non sanno di Latino, conoscano la pericolosa invasione del germanismo, da cui siamo minacciati».
[6] Di lui il Vallauri parla anche nella sua Storia della poesia in Piemonte (Torino 1841; vol. I, pp. 192 e 287).
[7] Evidente è il ricordo dell’opera del grammatico latino dei secoli IV/V Marziano Capella: De nuptiis Philologiae et Mercurii, in 9 libri misti di prosa e versi.
[8] A questo riguardo si può forse istituire un parallelo con un altro autore, anch’egli piemontese, anche se più anziano di almeno una generazione rispetto al Vallauri, che come il Nostro ebbe un’autentica venerazione per la lingua dei “buoni scrittori” dei secoli “aurei” della letteratura italiana, cioè Carlo Botta (1766-1837), del quale il Vallauri (Storia della poesia in Piemonte II, pp. 285sg.), a proposito del poema Camillo o Veio conquistata (1814, 18332), dice: «Il Botta […] vuol essere qui principalmente lodato siccome uno di que’ valorosi che nel cominciamento del secolo XIX concorsero col Monti e col Cesari nel lodevole disegno di purgare dalla corruzione la lingua italiana, la quale molti vestivano allora di panni forestieri», e ancora (a p. 286): «La lingua con cui è scritto il Camillo è la più forbita che si possa desiderare», anche se «egli è pur forza il confessare che questa scrittura manca della necessaria venustà» (ibid.).
[9] Allo stesso modi si comportava il Vallauri anche nello scrivere in latino, cosa per cui era rimproverato dal “ciceroniano” G. B. Gandino (cfr. ancora L. Berardo, cit., pp. 24sgg.).
[10] Per l’esame delle forme lessicali e del loro uso negli autori mi sono servito di S. Battaglia, Grande Dizionario della Lingua Italiana (GDLI), voll. I-XXI, Torino 1961-2002.

