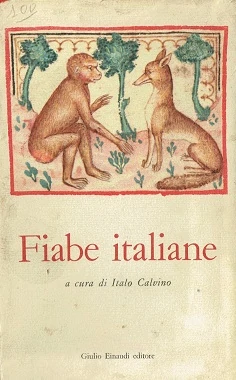
Chi si rivolge al mondo delle fiabe italiane ha l’opportunità di poterlo fare con l’ausilio dell’antologia di Italo Calvino (1923-1985)[1], il quale, nell’Introduzione, accenna alle motivazioni che lo portarono ad un impegno durato più di due anni, assorbendolo oltre le sue stesse previsioni e motivazioni culturali. Nel quadro della collana di testi delle fiabe classiche, alla Casa editrice Einaudi si pose, infatti, una «esigenza editoriale: si voleva pubblicare, accanto ai grandi libri di fiabe popolari e straniere, una raccolta italiana». Calvino si pose, quindi, di fronte alla materia in un’ottica professionale, ma non specialistica, valendosi della collaborazione di esperti, in primo luogo dello studioso di tradizioni popolari Giuseppe Cocchiara (1904-1965).
La lettura delle fiabe nei testi delle raccolte ottocentesche, il contatto con ricercatori e appassionati, lo portò ad un profondo coinvolgimento, quello stesso a cui vanno incontro tutti quelli che si addentrano nel mondo delle fiabe tradizionali e delle leggende, della cui stessa inafferrabilità e mistero si alimenta il piacere della lettura e della ricerca. «Mi pareva che dalla scatola magica che avevo aperto, la perduta logica che governa il mondo delle fiabe si fosse scatenata, ritornando a dominare sulla terra».
 Calvino si trovò di fronte alla problematica che era maturata dall’800, intorno alla raccolta del materiale e gli studi sulla tradizione orale in dialetto: se privilegiare il rigore filologico e la fedeltà ad un originale parlato o redigere una versione letteraria della fiaba, scegliendone le varianti migliori e combinandole tra di loro. È stato questo, di fatto, il criterio prevalente, a cominciare dai Fratelli Grimm. Anche i ricercatori che hanno fatto raccolte in dialetto, riferite a un’area specifica, hanno infine “creato” qualcosa di personale, come ne farebbe un nuovo narratore.
Calvino si trovò di fronte alla problematica che era maturata dall’800, intorno alla raccolta del materiale e gli studi sulla tradizione orale in dialetto: se privilegiare il rigore filologico e la fedeltà ad un originale parlato o redigere una versione letteraria della fiaba, scegliendone le varianti migliori e combinandole tra di loro. È stato questo, di fatto, il criterio prevalente, a cominciare dai Fratelli Grimm. Anche i ricercatori che hanno fatto raccolte in dialetto, riferite a un’area specifica, hanno infine “creato” qualcosa di personale, come ne farebbe un nuovo narratore.
D’altra parte la fiaba come opera letteraria autonoma, per quanto basata su tradizioni popolari, ha in Italia il suo capolavoro nel Pentamerone, Lo cunto de li cunti, (1634-6) di Giambattista Basile (1566-1632); la sua influenza nell’ambito europeo dimostra l’intreccio e le reciproche rispondenze ed influenze che vi sono tra testi d’autore e tradizione popolare orale, formando un complesso dal potente valore identitario.
Per Calvino non si poneva l’opzione “filologica”, in quanto l’obiettivo editoriale e il suo stesso orientamento culturale e politico erano per un’opera che desse una sintesi e una valorizzazione del patrimonio favolistico popolare italiano, favorendone la conoscenza e la lettura di bambini e adulti[2].
Egli era consapevole di quanto in essa andava perduto ed ebbe a giustificarsi nell’Introduzione con il proverbio toscano «La fiaba nun è bella, se sopra nun ci si rappella». In questo senso, Calvino veniva ad identificarsi nella figura del narratore, secondo una finzione che il lettore avverte nel manierismo che uniforma i testi delle fiabe.
I precedenti
Il precedente dichiarato è quello della raccolta dei fratelli Grimm (1812-22), nel loro intento di stabilizzare in un canone scritto la tradizione popolare in lingua tedesca. Senonché i Grimm attingevano ancora –non esclusivamente– alla tradizione orale e all’operazione letteraria ed artistica di scelta, scrittura e sintesi delle varie versioni delle fiabe si svolgeva al ridosso del dettato del narratore.
versioni delle fiabe si svolgeva al ridosso del dettato del narratore.
Calvino attinge invece a testi scritti, al patrimonio di ricerche folkloriche dall’800 in poi, alle raccolte di Domenico Comparetti (1835-1927), Vittorio Imbriani (1840-1886), Gherardo Nerucci (1828-1906), Giuseppe Pitrè (1841-1916) e molti altri. Selezionando, collazionando tali testi e volgendo in lingua i dialetti regionali, Calvino fonde motivi e trame, dà loro coerenza, adotta «un italiano favolistico, corretto ma svagato», che attinge ai toni della narrazione popolare, ma che da essa prende sottilmente le distanze.
Per queste vie, Calvino si colloca nella serie degli scrittori di fiabe, da Carlo Collodi (1826-1890) a Emma Perodi (1850-1918) ed a Fata Nix (1866-1933), che hanno attinto dalla tradizione o dalle fiabe d’autore, trame, personaggi, motivi, reinventandole, ovvero creando un loro originale mondo fantastico, e immettendo nei testi motivi pedagogici e sociali, nonché toni romanzeschi da letteratura popolare.
La vasta bibliografia dà conto dei materiali su cui Calvino e i suoi collaboratori operarono. Le Note alle singole fiabe, in cui si menzionano le fonti e le varianti utilizzate, danno l’idea dell’ampiezza, profondità e varietà del patrimonio, verosimilmente solo una frazione di quella che fu l’antica tradizione orale. Testi e note hanno l’esito e il pregio d’invogliare a conoscerle (tali fonti) e con esse le versioni tralasciate, i linguaggi divenuti ostici di cui erano rivestite. E da Calvino si torna volentieri a Imbriani, a Nerucci, a Pitrè, penetrando in un mondo meno levigato, meno stilizzato, ma denso dell’ineffabile materia fantastica delle fiabe e della loro antichissima risonanza. E si rimpiange che, nelle ricerche antropologiche e sul folklore, poco si sia conservata memoria dei narratori (per lo più donne), dei luoghi, delle circostanze, in cui la fiaba fu trasmessa nella memoria di altri o fermata sulla carta.
Nell’Introduzione Calvino dà una panoramica delle teorie e degli studi internazionali di fiabistica, dichiarandosi «non specialista», ma ponendosi di fronte al mondo della fiaba come ad un complesso che ha natura, origini e leggi sue proprie e come tale può essere catalogato, censito, categorizzato per motivi, ma non “interpretato”. In questo senso Calvino non anticipa le tendenze di destrutturazione sociologica o psicanalitica della fiaba, ma anzi rivendica l’integralità di essa, la sua visionarietà e l’irriducibile arbitrio del narratore.
Un antidoto alla banalizzazione
Un merito delle Fiabe italiane di Calvino è quello di aver reso percepibile e trasmissibile – anche materialmente, nella forma-libro – un patrimonio disseminato presso Istituti di ricerca, biblioteche, archivi, e tutto questo nel momento in cui veniva ad evanescenza – e, con la televisione, a scomparsa – la tradizione orale.

Ci troviamo oggi in una fase successiva, in cui la stessa abilità alla lettura è messa in discussione e l’impoverimento del linguaggio, l’imperio dei luoghi comuni, la convenzionalità di situazioni, ambienti e personaggi imposta dai media tolgono alla fiaba la sua libertà fantastica e infine la sua ragion d’essere. Gli aggiornamenti e l’omologazione al “politicamente corretto”, che imperversano oggi intorno alle fiabe, non sono quindi riletture di esse, ma meri pretesti mediatici, realizzati attraverso la combinatoria di un numero limitato e ripetitivo di elementi.
L’antologia di Calvino si conferma, sotto quest’aspetto, come un antidoto e uno strumento utile per inoltrarsi, orientarsi ed apprezzare un patrimonio incomprimibile in canoni conformistici.
Nello stesso tempo, Le Fiabe italiane del narratore Calvino sono l’espressione della sua poetica, riportando la fantasmagorica varietà dei materiali ad una cifra stilistica unica e ad una visione del mondo che è quella dell’autore; ne consegue (ma è una sua scelta dichiarata) una levigatura, una cesura dei toni alti, delle punte estreme del feroce, del terrorifico, del beffardo; uno sguardo partecipe, ma ironico, talvolta nostalgico, talvolta distaccato. Per quanto concluda con «Le fiabe sono vere», si avverte il disincanto, lo stacco ideologico, il metro profano che uniforma ad una tonalità media il sacro e il mistero.
All’estremo opposto, sta la visione della fiaba di John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973), espressa nella sua opera narrativa e nel suo saggio Sulle fiabe[3], in cui propugna la funzione utopica della fiaba e una visione mistica della fantasia:
«Con la fantasia l’Uomo può assistere effettivamente al dispiegarsi e al molteplice arricchimento della creazione. Tutte le narrazioni si possono avverare, pure alla fine, redente, possono risultare insieme simili e dissimili dalle forme che avevamo dato loro, proprio come l’Uomo, finalmente redento, sarà simile e dissimile, insieme, rispetto all’uomo caduto a noi noto.»
[1] Fiabe italiane. Raccolte dalla tradizione popolare durante gli ultimi cento anni e trascritte in lingua dai vari dialetti (ed. Einaudi 1956). Le citazioni sono dall’Introduzione dell’Autore.
[2] Ciò non toglie che vi furono discussioni, tra la casa editrice, che puntava ad una “strenna” per un vasto pubblico, Calvino e vari folkloristi, sugli aspetti filologici e creativi. Prevalse tra gli studiosi il metodo di Cocchiara, favorevole alla più ampia fruibilità del testo, e quindi ad una riscrittura radicale delle fiabe.
[3] J.R.R.Tolkien, Sulle fiabe in Albero e foglia (trad. it. Rusconi 1976).

